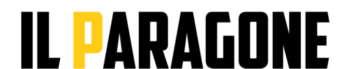di Thomas Fazi.
Come nelle più prevedibili delle sceneggiature hollywoodiane, proprio quando il mostro sembrava ormai morto, eccolo rialzarsi per un (ultimo?) colpo di scena.
Fino all’altro giorno, infatti, erano in molti a dare per morto il MES. Per chiarezza: qui non stiamo parlando del cosiddetto “MES sanitario”, ovvero della nuova linea di credito dalle “condizionalità limitate” riservata agli Stati per le spese sanitarie, che continua ad essere oggetto di un accesso dibattito e di cui abbiamo parlato in più occasioni, ma del Meccanismo europeo di stabilità nella sua accezione più ampia, in quanto organo intergovernativo permanente che esiste dal 2011 e la cui funzione fondamentale è quella di «concedere, sotto precise condizioni, assistenza finanziaria ai paesi membri che trovino temporanee difficoltà nel finanziarsi sul mercato». Parliamo in sostanza dell’organo impiegato (insieme ai suoi predecessori, il FESF e l’EFSM) nel “salvataggio finanziario”, per usare un eufemismo, in cambio di “riforme”, per usare un altro eufemismo, di Grecia, Irlanda, Portogallo, Spagna e Cipro.
Per capire di cosa parliamo può essere utile richiamare un episodio che riguarda Klaus Regling, il direttore generale del MES, che, come ricorda Carlo Clericetti, «dispone di amplissimi poteri e le cui azioni, secondo una esplicita previsione dello statuto del fondo, non possono essere contestate in nessun modo, nemmeno per via giudiziaria». Nel suo libro di memorie Adulti nella stanza, l’ex ministro delle Finanze greco Yanis Varoufakis racconta che nel tentativo di ottenere un rinvio al soffocante pagamento delle rate dei prestiti si rivolse direttamente a Regling. «Per pagare la rata nei termini stabiliti non avrei i soldi per stipendi e pensioni», gli disse Varoufakis. E Regling, senza battere ciglio, rispose: «E allora non pagare stipendi e pensioni». Questo tanto per inquadrare il plenipotenziario capo del MES.
Di questo MES – cioè del MES in quanto tale, diversamente dal “MES sanitario” – ormai non si parlava quasi più. Non più di un mese fa l’autorevole (e ferreamente europeista) Jacques Delors Centre ha pubblicato un paper in cui veniva bocciata senza appello qualunque ipotesi di riforma del MES, giudicato ormai «irrilevante». Come scriveva Lucas Guttenberg, vicedirettore del centro: «Non ha senso riformare un meccanismo che ha dimostrato di essere politicamente impraticabile con misure che non affrontano il suo difetto centrale», ovverosia lo stigma politico associato all’utilizzo dello stesso. Sull’onda di quel paper, persino David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, fino a poco prima tra i più veementi sostenitori del MES, aveva dichiarato «ormai anacronistico» il MES.
Ma proprio quando sembrava ormai spacciato, ecco che il “mostro” del MES è riemerso dalle ceneri. Più feroce che mai. Nella riunione del 30 novembre scorso, infatti, l’Eurogruppo – l’organo che riunisce i ministri dell’Economia dei paesi dell’eurozona – ha dato il via libera, con l’assenso dell’Italia nella persona del suo ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, al processo di riforma del MES.

La notizia ha provocato un certo sconcerto. Se è vero, infatti, che la riforma del MES era già stata oggetto di un accordo politico «in linea di principio» maturato tra giugno e dicembre 2019 – la cui formalizzazione era poi stata lasciata in sospeso a causa del sopraggiungere della pandemia –, è altresì vero, però, che al tempo il primo ministro Giuseppe Conte aveva promesso «il pieno coinvolgimento del Parlamento in tutti i passaggi del negoziato sul futuro della UE e sulla conclusione della riforma del MES», come ribadito dalla risoluzione parlamentare del 11 dicembre 2019.
Ma ciò non è avvenuto. In occasione del succitato Eurogruppo, infatti, il ministro Gualtieri ha ribadito l’appoggio dell’Italia alla riforma senza che il Parlamento fosse stato minimamente consultato. In verità, che il governo italiano avesse già dato il proprio assenso alla riforma del MES era chiaro da tempo. Non a caso poco prima dell’Eurogruppo scorso il ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire aveva dichiarato: «Non ho ragioni per aspettarmi che gli impegni politici presi dall’Italia» un anno fa sulla riforma del MES «non siano affidabili»; «il testo è chiuso» e «ora ci aspettiamo che tutti rispettino l’impegno politico preso, e che questo sia rispecchiato anche nelle procedura nazionali».
E infatti così è stato. Ma d’altronde non avevamo dubbi. Con il risultato che adesso al Parlamento – che il 9 dicembre è chiamato a votare una risoluzione sulla riforma del MES in vista del prossimo Consiglio europeo del 10-11 dicembre – non rimane altra scelta che “prendere o lasciare” una riforma su cui non ha avuto alcuna voce in capitolo. Alla faccia del «pieno coinvolgimento del Parlamento».
In cosa consiste, dunque, questa riforma? Le modifiche chiave sono due: una ulteriore stretta sulle condizioni per accedere ai finanziamenti del MES e la possibilità per il MES di prestare denaro al Fondo di risoluzione unico per le crisi bancarie, in caso di incapienza di quest’ultimo.
In questa sede ci concentreremo sul primo punto, che è indubbiamente quello che presenta gli aspetti più critici. Attualmente il MES prevede già due differenti linee di credito per quei paesi che abbiano «difficoltà nel finanziarsi sul mercato»: una “precauzionale” (Precautionary Conditioned Credit Line, PCCL), riservata a quei paesi con “fondamentali solidi”, che rispettano le prescrizioni del Patto di stabilità e crescita in termini di deficit e/o debito pubblico, che non presentano squilibri macroeconomici eccessivi e che non hanno problemi di stabilità finanziaria; e una “a condizionalità rafforzata” (Enhanced Conditions Credit Line, ECCL), destinata ai paesi che non rispettano pienamente i suddetti criteri. Ad oggi, entrambe le linee di credito prevendono la firma di memorandum d’intesa con il MES, con l’unica differenza che la linea di credito “rafforzata” prevede, come si evince dal nome, condizionalità più rigorose.
Cosa cambierebbe, dunque, con la riforma in questione? In sostanza, la riforma rende più stringenti i criteri per accedere alla linea di credito precauzionale, stabilendo che questa può essere utilizzata solo dai paesi non soggetti a procedure per disavanzo o per squilibri macroeconomici eccessivi, ed eliminando l’obbligo della firma di un memorandum d’intesa (cioè di un programma dettagliato di “aggiustamento strutturale”: leggasi austerità e “riforme strutturali”) in caso di PCCL, che invece sarà previsto solo per quei paesi che accedano a una linea di credito rafforzata. In sostanza il “nuovo” MES esacerberebbe la distinzione a monte tra paesi “buoni” e paesi “cattivi”, proprio in base a quei parametri (Patto di stabilità e Fiscal Compact) che oggi sono temporaneamente sospesi a causa della pandemia ma di cui evidentemente, come rivela la riforma in oggetto, se ne prevede la reintroduzione, addirittura in forma rinforzata.
Al tal fine il MES sarebbe tenuto ad effettuare un monitoraggio sistematico e continuo della situazione macroeconomica e finanziaria degli Stati. In ultima analisi, insomma, come si legge in un appello sottoscritto da più di trenta economisti e giuristi, «il MES non è uno strumento di aiuto, ma di controllo, un controllo affidato a funzionari senza nessuna legittimazione democratica e il cui compito statutario è agire “nell’interesse del creditore”, indipendentemente dalle conseguenze che ciò può provocare al paese sottoposto alla sua potestà».
Come se non bastasse, la riforma prevede che anche in caso di ECCL, cioè di una linea di credito rafforzata, il MES potrebbe intervenire solo a favore di Stati il cui debito viene giudicato “sostenibile”, arrivando a prevedere, nel caso di valutazione negativa, una vera e propria ristrutturazione preventiva del debito, che, pur non essendo automatica, diverrebbe di fatto una precondizione per accedere al prestito. Non a caso la riforma prevede anche l’introduzione di nuove regole per facilitare proprio le procedure di ristrutturazione del debito pubblico.
Tra queste, l’obbligo per tutti gli Stati membri, a partire dal 2022, di emettere titoli di Stato con una nuova clausola di azione collettiva (collective action clause, CAC) a voto unico (single-limb), che renderà più facile la ristrutturazione del debito pubblico qualora esso dovesse essere giudicato non sostenibile dal MES (in un’analisi congiunta con la Commissione europea), in quanto non sarà più possibile per un singolo creditore che detenga una determinata percentuale di una certa tipologia di titoli bloccare la ristrutturazione.
Quest’ultimo aspetto è particolarmente problematico per paesi ad alto debito pubblico come l’Italia, poiché rischia di creare le condizioni per una classica profezia autoavverantesi, incentivando gli investitori – magari a seguito di una valutazione di sostenibilità del debito dall’esito negativo – a sbarazzarsi dei titoli italiani per paura di una ristrutturazione futura, conducendo così lo Stato emittente a perdere l’accesso ai mercati (un punto su cui torneremo) con la conseguente entrata in scena dei prestiti del MES condizionati ad un programma di aggiustamento macroeconomico (nel migliore dei casi) o, appunto, a una ristrutturazione del debito. Insomma, come nota correttamente Giuseppe Liturri, siamo di fronte a uno strumento che rischia con la sua sola presenza di causare la malattia che si propone di curare.
«Uno strumento di sostegno che sembra pensato per penalizzare maggiormente proprio chi di quel sostegno potrebbe avere maggiore bisogno»: così lo definì il presidente del CER (Centro Europa Ricerche) Vladimiro Giacché in un’audizione parlamentare a fine 2019 e, dopo un anno, è difficile trovare una sintesi migliore. «Sono strumenti di assistenza finanziaria perfetti per innescare una nuova crisi del debito, perseverando in tal modo nei gravi errori del 2011-12», aggiunse Giacché. Esattamente negli stessi giorni, il governatore di Bankitalia Ignazio Visco identificò perfettamente il rischio di ristrutturazione del debito specificando che «tale riforma si inserisce fra le iniziative mirate a ridurre l’incertezza circa le modalità e i tempi di una possibile ristrutturazione di un debito pubblico. […] I benefici contenuti e incerti di un meccanismo per la ristrutturazione del debito vanno valutati a fronte del rischio enorme che si correrebbe introducendolo: il semplice annuncio di una tale misura potrebbe innescare una spirale perversa di aspettative di insolvenza, suscettibili di autoavverarsi».
Curiosamente, lo stesso Giuseppe Conte, nel giugno del 2018, spiegò l’opposizione dell’Italia alla riforma del MES proposta allora da Germania e Francia – quasi identica nella forma alla riforma a cui oggi invece il governo Conte ha dato il suo assenso – col fatto che esso avrebbe finito per «costringere alcuni paesi verso percorsi di ristrutturazione predefiniti, con sostanziale esautorazione del potere di elaborare, in autonomia, politiche economiche efficaci», nella misura in cui i «nuovi vincoli al processo di ristrutturazione del debito potrebbero contribuire, proprio essi, all’instabilità finanziaria anziché prevenirla». «Non vogliamo pericolose duplicazioni con i compiti della Commissione europea per la sorveglianza fiscale», aggiunse Conte, perché queste «rischierebbero peraltro di delegittimare la base democratica di queste funzioni essenziali per la stabilità finanziaria».

Viene da chiedersi, anche se sappiamo che si tratta di una domanda retorica, cosa abbia indotto Conte a cambiare idea in merito alla riforma.
Non ci vuole molto a capire che una misura di questo tipo avrebbe conseguenze devastanti in particolare per l’Italia. L’ultima valutazione di sostenibilità del debito si è conclusa positivamente per il nostro paese, ma solo perché contiene una crono-tabella che prevede per l’Italia una progressiva diminuzione del rapporto debito/PIL per mezzo di una graduale riduzione del disavanzo complessivo, e il ritorno a un consistente avanzo primario, a partire dai prossimi anni. In sostanza, un pieno ritorno a regole e politiche fiscali pre-crisi, a cui ci si aspetta che il paese debba attenersi, del tutto incompatibile con una ipotesi di ripresa economica del nostro paese. Più banalmente, però, si tratta di un obiettivo del tutto impraticabile.
Con il risultato, come ha scritto di recente Wolfgang Münchau, che «non appena le regole fiscali saranno ripristinate, l’Italia si ritroverà in violazione dei vincoli di debito e soggetta a una procedura per disavanzo eccessivo, con la necessità di effettuare un aggiustamento strutturale di forse 4 punti percentuali del PIL». A quel punto, dice Münchau, «[s]embra inevitabile che il debito pubblico italiano finirà per dover essere ristrutturato». Anzi, secondo Münchau, il significato del MES “riformato” (a partire dalla clausola single-limb) è precisamente «quello di preparare il terreno per la ristrutturazione del debito italiano, senza affermarlo esplicitamente».
Quanto detto finora dovrebbe essere sufficiente a comprendere perché la riforma del MES sia da rigettare senza se e senza ma. Tuttavia, si impone a questo punto una considerazione di ordine più generale. Come abbiamo ormai spiegato ad libitum, il rischio che uno Stato possa trovarsi “in difficoltà nel finanziarsi sul mercato” o addirittura costretto a una ristrutturazione forzata del proprio debito pubblico – presupposto su cui si basa la stessa ragion d’essere del MES – non si pone neanche per quegli Stati “normali” che dispongono della sovranità monetaria, cioè che emettono debito nella propria valuta.
Uno Stato che goda della garanzia esplicita di una banca centrale, infatti, non potrà mai rimanere a corto di fondi – né potrà mai trovarsi impossibilitato a rifinanziare il proprio debito ed essere dunque costretto a fare default o a ristrutturare il proprio debito – nel caso in cui non vi siano investitori disposti a comprare i titoli emessi dallo Stato, poiché la banca centrale può sempre intervenire per sopperire a una eventuale carenza di acquirenti privati o per rimborsare i titoli in scadenza (quello che in gergo tecnico si chiama rollover) attraverso la creazione di denaro dal nulla. Per la stessa ragione, i mercati non potranno mai imporre un rialzo dei tassi di interesse a uno Stato che emette moneta.
Non è un caso che in nessun paese “normale” esistano strumenti come il MES – cioè uno strumento nato per prestare ai paesi la propria valuta in cambio di “riforme strutturali” e tagli alla spesa pubblica.
Ora, qualche anima bella si era illusa che la sospensione del Patto di stabilità e il nuovo corso della BCE – che dall’inizio della pandemia si sta comportando quasi come una banca centrale “normale”, offrendo un sostegno incondizionato ai titoli di Stato degli Stati membri, di fatto monetizzando tutto o quasi il nuovo debito di paesi come l’Italia – rappresentasse una rivoluzione di lungo termine nell’assetto istituzionale della zona euro, e che dunque da ora in avanti l’Italia avrebbe semplicemente potuto finanziarsi “sui mercati” – o meglio, nei fatti, presso la BCE –, come fanno un po’ tutti i paesi “normali” del mondo.
Il fatto che oggi si torna a parlare di MES, però, è la dimostrazione di quanto fossero infondate tali speranze, come sosteniamo da tempo. La verità è che nelle segrete stanze di Bruxelles e di Francoforte si discute da tempo di come porre fine all’attuale stato di “normalità eccezionale” per tornare a quello stato di “eccezionalità normale” che è la stessa ragion d’essere dell’euro: determinare una situazione di scarsità artificiale di denaro, attraverso una netta separazione istituzionale tra governi e istituto di emissione, per giustificare l’imposizione di politiche di stampo neoliberale (smantellamento del welfare, privatizzazioni, deregolamentazione del mercato del lavoro ecc.).
L’obiettivo è dunque tornare quanto prima a una situazione in cui la BCE torni a fare – caso unico nel panorama delle banche centrali – lo “spacciatore di ultima istanza”, laddove cioè l’intervento calmierante della banca centrale sia subordinato alla sottoscrizione di un memorandum d’intesa col MES – ma lo stesso discorso vale per il Recovery Fund, che presenta condizionalità altrettanti stringenti –, al fine di sottoporre gli Stati a una sorta di “amministrazione controllata” attraverso le famigerate “condizionalità”.
Nel futuro prossimo possiamo dunque aspettarci che la BCE, con la scusa che è passata la fase emergenziale, inizierà progressivamente a ridurre i propri acquisti di titoli pubblici – come prevede lo stesso Münchau –, non lasciando altra scelta agli Stati ancora in forte disavanzo e con un alto debito, come lo sarà l’Italia, a ricorrere al MES. In questo senso, come nota l’economista Emiliano Brancaccio, l’argomentazione principale invocata dai vertici del Movimento 5 Stelle per giustificare il proprio appoggio alla riforma del MES – ovverosia che l’approvazione della riforma da parte del Parlamento non significa che in futuro l’Italia sarà costretta a ricorrere ai prestiti del MES – è una fuorviante illusione: «la riforma del MES ha sempre avuto lo scopo chiave di affrancare la BCE dal ruolo di “market maker”, di domatore dei mercati. Ma se quel ruolo viene abbandonato la crisi economica si tramuterà in crisi finanziaria, e a quel punto sarà inevitabile ricorrere ai prestiti MES, con il corollario delle ristrutturazioni e con l’inevitabile ritorno alla dottrina dell’austerity».
In verità, non appena la BCE comincerà a rimodulare la propria politica monetaria, l’Italia si vedrà costretta a sottostare al ricatto finanziario dell’Europa anche in assenza del MES. Il problema, insomma, non è il MES, ma l’euro. In tal senso, rappresenta una pericolosa illusione anche quella dei cosiddetti “europeisti critici”, che si oppongono alla riforma del MESsenza però mettere in discussione l’appartenenza dell’Italia all’architettura dell’eurozona.
Ora e sempre la soluzione rimane una sola: #Italexit.