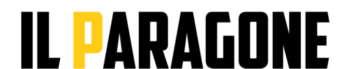di Thomas Fazi.
Su una cosa praticamente tutti – giornalisti, commentatori, esponenti del governo (e persino alcuni dell’opposizione!), comuni cittadini – sembrano essere d’accordo: l’accordo raggiunto in sede europea sul cosiddetto Recovery Fund rappresenta una «grande vittoria» per l’Italia e un «evento storico» per l’Europa.
Per capire se è veramente così, vediamo di cosa si tratta. Partiamo innanzitutto dall’aspetto strettamente finanziario. L’accordo si compone di due pezzi: il “Next Generation EU” (NGEU), ovvero i famigerati 750 miliardi che la Commissione potrà prendere a prestito sui mercati; e il quadro finanziario pluriennale (QFP), ovvero il bilancio europeo classico, che andrà dal 2021 al 2027. Per quanto riguarda il NGEU, il totale (750 miliardi) rimane invariato rispetto alla proposta originale della Commissione, ma cambia di molto la sua ripartizione. Sono stati ridotti i “trasferimenti a fondo perduto” – da 500 a 390 miliardi – e sono stati aumentati i “prestiti bilaterali”, da 250 a 360 miliardi. Per quanto riguarda il bilancio europeo, invece, esso avrà in dotazione poco più di mille miliardi di euro, un po’ meno rispetto a quanto proposto inizialmente dalla Commissione.
Per far quadrare i conti, sono stati ridotte alcune voci di spesa del bilancio comunitario. Sono state introdotte anche delle importanti modifiche ai cosiddetti “rebates”, ovvero gli sconti che vengono storicamente fatti ad alcuni Stati che sono contribuenti netti al bilancio comunitario: Danimarca, Olanda, Germania, Austria, Svezia. L’Olanda, per esempio, riceverà ogni anno circa 500 milioni in più rispetto a quanto era inizialmente previsto. L’ammanco dovrà essere coperto dagli altri Stati membri: questo comporterà un’ulteriore riduzione del trasferimento “netto” dai paesi ricchi a quelli poveri (che già non era enorme) attraverso il bilancio comunitario. Fatto interessante: l’Italia e la Francia, pur essendo contribuenti netti al bilancio comunitario, non hanno nessun “rebate”; la Germania, per qualche ragione, sì.

Veniamo ora al punto che ci riguarda più da vicino: quanti soldi spetteranno all’Italia? La prima cosa da dire è che per ora non esistono cifre ufficiali. Nella ripartizione del NGEU, il metodo di calcolo per il periodo 2021-2022 resta quello inizialmente proposto dalla Commissione, mentre il calcolo per il 2023 prenderà in conto la caduta del PIL cumulata nel periodo 2020-2022. Con le dovute cautele, questo ha portato alcuni a stimare che l’Italia dovrebbe ottenere circa 80 miliardi di trasferimenti a fondo perduto (poco meno degli 85 inizialmente previsti) e circa 127 miliardi di prestiti bilaterali, ovvero 38 miliardi più di quanto previsto inizialmente.
Partiamo dalla questione dei trasferimenti: 80 miliardi di euro “a fondo perduto” sono una bella cifra, ma c’è un dettaglio – non esattamente di poco conto – da prendere in considerazione. Se è vero, infatti, che i singoli Stati non saranno chiamati a rimborsare individualmente le somme ricevute – a differenza di quanto saranno tenuti a fare con i prestiti bilaterali –, è altrettanto verso che saranno chiamati a rimborsare (in base al PIL) la parte del debito comune emesso dalla Commissione destinata ai trasferimenti. Dunque, alla fine, come vale già oggi per il bilancio europeo, a determinare se un paese ci avrà guadagnato o meno dai trasferimenti inerenti al NGEU sarà il saldo finale tra la somma che avrà ricevuto dal fondo in questione e la somma che invece sarà chiamato a rimborsare. Tanto per capirci: anche oggi l’Italia riceve finanziamenti “a fondo perduto” dalla UE, ma il suo saldo complessivo è negativo, il che vuol dire che l’Italia versa più soldi di quanti ne riceva dall’Europa.
Ora, secondo le stime che girano – lo ripetiamo, non c’è nulla di ufficiale ancora – l’Italia dovrebbe essere chiamata a versare circa 50-60 miliardi. In quel caso parleremmo di un effetto positivo “netto” di circa 20-30 miliardi spalmati su sei anni: pochi miliardi l’anno. Ma se anche volessimo essere generosi, e volessimo considerare tutti e 80 i miliardi un reale trasferimento netto (cosa che non è), staremmo comunque parlando di una cifra estremamente esigua: 80 miliardi spalmati fino al 2026 rappresentano uno “stimolo” pari all’incirca all’1 per cento del PIL all’anno, a fronte di un crollo del PIL che per il nostro paese si prospetta a doppia cifra (-15 per cento solo nel primo semestre del 2020 secondo l’Ufficio parlamentare di bilancio) e di un tasso di crescita che rischia di tornare ai livelli pre-COVID solamente nel 2025. Non a caso il fabbisogno finanziario per una ripresa consistente è stato calcolato attorno ai 500 miliardi da un economista dell’FMI.

Per quanto riguarda i 127 miliardi di prestiti stimati, invece, saranno ripagati secondo tempi e tassi di interesse ancora da determinare dagli Stati membri che decideranno di farne uso. L’unico “vantaggio” di questo tipo di prestiti sarebbe il “differenziale” fra gli interessi pagati dallo Stato italiano sui titoli che emette da solo rispetto a quelli pagati sui titoli emessi dalla Commissione. Ma come abbiamo più volte detto, l’unica ragione per cui esiste questo differenziale è la perversa architettura istituzionale dell’eurozona. La domanda che dovremmo porci, infatti, è la seguente: perché sui nostri titoli di Stato a dieci anni paghiamo attualmente un tasso di interesse (poco più dell’1 per cento) più alto di quello del periodo pre-pandemia? Perché la BCE ha permesso ai tassi di salire in un momento di emergenza come questo, quando quello che dovrebbe fare una banca centrale in tempo di crisi – e che infatti hanno fatto e stanno facendo tutte le altre banche centrali, incluse quelle dei paesi emergenti – è l’opposto: far scendere i tassi di interesse per facilitare le necessità di finanziamento dei governi? Perché, in definitiva, siamo messi nella condizione di dover scegliere tra indebitarci “sui mercati” a tassi relativamente onerosi e indebitarci nei confronti della UE a tassi più convenienti?
Il presupposto da cui partire è che non c’è nulla di “naturale” nel tasso di interesse che attualmente paghiamo sui nostri titoli di Stato. I tassi di interesse, in ultima analisi, vengono decisi dalla banca centrale: da un punto di vista strettamente tecnico, la BCE, se lo volesse, potrebbe tranquillamente portare i tassi di interesse sui nostri titoli di Stato a zero. Non ci interessa discutere in questa sede se non la faccia per ragioni “statutarie” o politiche. Il punto è che se oggi paghiamo sui nostri titoli di Stato un tasso di interesse tale da rendere “attrattiva” la prospettiva di indebitarci nei confronti della UE (con tutto ciò che questo comporta, come vedremo), è unicamente una conseguenza dell’appartenenza alla stessa architettura monetaria della UE.
Considerazioni politiche a parte, comunque, 127 miliardi spalmati su sei anni, anche se sommati agli 80 miliardi di trasferimenti (netti o meno), sono del tutto insufficienti ad arginare il collasso economico e sociale del nostro paese. Tanto per fare un esempio, il Regno Unito, che ha una popolazione pari a quella italiana, per far fronte alla pandemia e ai relativi danni economici, ha annunciato un deficit della stessa entità per il solo 2020-21. E ovviamente senza chiedere il permesso a nessuno.

I tempi, poi, sono un’altra variabile penalizzante: i soldi inizieranno a essere versati soltanto nel 2021, saranno “impegnati” (cioè sarà deciso dove e a chi andranno) fino al 2023 e liquidati entro il 2026. Ovviamente tali tempi sono completamente incompatibili con l’esigenza di finanziare immediatamente la ripresa, prima che i danni produttivi e sociali diventino irreparabili.
Alla luce di quanto detto, è evidente che l’unica soluzione per evitare il collasso dell’economia italiana è il mantenimento di un consistente disavanzo pubblico negli anni a venire. Ma su questo pesa sia la spada di Damocle della BCE (se/quando verrà dismesso il programma di acquisti di titoli di Stato iniziato con la pandemia, il rischio è di una nuova crisi stile 2011), sia il ritorno dell’austerità. Quel minimo di stimolo fiscale che è lecito aspettarsi dal programma – indipendentemente che i fondi arrivino sotto forma di prestiti o di trasferimenti – rischia, infatti, di essere più che controbilanciato dal ritorno del “consolidamento fiscale”, in ossequio al Patto di stabilità e al Fiscal Compact. Su questo punto il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, è stato molto chiaro: passata l’emergenza i paesi dovranno rientrare del debito e del deficit accumulati per gestire la crisi, assieme agli squilibri pregressi.
Questo vale soprattutto per questi paesi che hanno un alto debito come l’Italia. La più recente valutazione della sostenibilità del debito italiano (quella realizzata per il nuovo MES “pandemico”) contiene una crono-tabella che prevede per l’Italia un disavanzo complessivo di bilancio del 2 per cento nel 2026, e dunque un consistente avanzo primario, maggiore di quelli richiesti all’Italia negli anni passati (considerato che il disavanzo è lo stesso previsto per il 2019, ma le somme pagate per interessi saranno più elevate nel 2026, dato l’incremento del rapporto debito-PIL). In sostanza, un pieno ritorno a regole e politiche fiscali pre-crisi, a cui ci si aspetta che il paese debba attenersi, del tutto incompatibile con una ipotesi di ripresa economica del nostro paese.

Come ha commentato Massimo D’Antoni, da un lato si chiederà all’Italia di continuare a tagliare le spese (e dunque di ridurre l’entità della spesa pubblica sotto il proprio controllo) per finanziare il nostro avanzo primario e il Recovery Fund (di cui siamo anche contribuenti), mentre dall’altro ogni nuova spesa verrà a dipendere dal Recovery Fund e quindi “passerà” per Bruxelles.
E questo ci porta alla questione delle famigerate condizionalità. Come ha commentato Federico Fubini sul Corriere della Sera, fa un po’ sorridere chi ieri si preoccupava delle condizionalità del MES e oggi plaude al Recovery Fund: «In questo maxi-prestito c’è un effetto paradossale e forse sornionamente voluto da qualcuno a Bruxelles: quei 38 miliardi di prestiti in più all’Italia dal Recovery Fund sono quasi uguali all’ammontare offerto in prestito dal Meccanismo europeo di stabilità (MES), che il governo sembra non volere. Le condizioni finanziarie sono simili, ma quelle politiche diverse: il MES, che l’Italia per ora sta rifiutando, non richiede riforme; il Recovery Fund, che il governo non può rifiutare, ne prevede invece di molto precise. E vigilate da vicino». Insomma, abbiamo accantonato (per ora) il MES – che ufficialmente non prevedeva condizionalità se non l’obbligo di destinare i fondi alle spese sanitare (anche se sappiamo che le cose non stavano proprio così) – per affidarci a uno strumento che invece prevede stringenti condizionalità a tutti i livelli.
I paesi beneficiari delle risorse UE, infatti, dovranno rispettare le raccomandazioni specifiche per paese della Commissione (comprese quelle del 2019), oltre ai nuovi obiettivi (“Green Deal” e digitalizzazione), in linea con la sorveglianza rafforzata dei bilanci nazionali prevista dal “Semestre europeo”. Riforme strutturali, insomma. Per avere un’idea del tipo di “raccomandazioni” di cui parliamo, consiglio la lettura di un recente rapporto commissionato dall’europarlamentare della Linke Martin Schirdewan, che si è preso la briga di studiarsi tutte le raccomandazioni formulate dalla Commissione europea nell’ambito del Patto di stabilità e crescita e della Procedura per gli squilibri macroeconomici tra il 2011 e il 2018.
I risultati sono agghiaccianti. Lo studio mostra come, oltre ad insistere ossessivamente sulla riduzione della spesa pubblica, la Commissione si sia concentrata in particolare sulla riduzione della spesa relativa alle pensioni, alle prestazioni sanitarie e all’indennità di disoccupazione, oltre a chiedere il contenimento della crescita salariale e la riduzione delle misure di garanzia della sicurezza sul lavoro. In particolare, dall’introduzione del semestre europeo nel 2011 fino al 2018, la Commissione ha formulato ben 105 raccomandazioni distinte nei confronti degli Stati membri affinché aumentassero l’età pensionabile e/o riducessero la spesa pubblica relativa alle pensioni e all’assistenza per gli anziani. Inoltre, ha anche formulato 63 raccomandazioni ai governi affinché riducessero la spesa per l’assistenza sanitaria e/o esternalizzassero o privatizzassero i servizi sanitari. Infine, la Commissione ha formulato 50 raccomandazioni volte a reprimere la crescita dei salari e 38 raccomandazioni volte a ridurre la sicurezza sul lavoro, le tutele occupazionali contro il licenziamento e i diritti di contrattazione collettiva di lavoratori e sindacati.

Come se non bastasse, gli olandesi hanno insistito per includere nell’accordo un “super freno di emergenza”, che permetterà a uno o più Stati membri di appellarsi al Consiglio europeo (che avrà l’ultima parola, con voto a maggioranza qualificata) per bloccare gli esborsi a un altro paese, se insoddisfatti delle riforme richieste da Bruxelles o della loro attuazione. Non un vero e proprio diritto di veto, ma comunque qualcosa che lascerà l’esborso dei fondi in una situazione di perenne incertezza politica.
Questa è la vera polpetta avvelenata del Recovery Fund: l’usurpazione definitiva di quel minimo di autonomia di bilancio – e dunque di democrazia – che ci era rimasta. Finalmente, a colpi di crisi e di emergenze (spesso e volentieri costruite a tavolino), le élite nordeuropee sono riuscite ad ottenere, con la complicità di una classe dirigente italiana venduta e pusillanime, quello che vanno agognando da sempre: un controllo politico totale della politica economica dei paesi mediterranei. I programmi nazionali di riforma, a cui saranno soggetti i fondi del NGEU, sono infatti programmi che vanno ben oltre gli interventi materialmente finanziati dal fondo in questione. Essi, infatti, prevedono interventi di sburocratizzazione, riforma fiscale, riforma del mercato del lavoro, del welfare, delle pensioni ecc., che vanno ben al di là di ciò che viene finanziato dal NGEU o da altri fondi europei (che sono essenzialmente infrastrutture, incentivi alle imprese, trasferimenti ai cittadini, servizi o formazione). Stiamo assistendo, insomma, a un vero e proprio commissariamento de facto degli Stati politicamente più deboli ed economicamente più bisognosi di assistenza finanziaria esterna, a partire dall’Italia.

Come commenta Riccardo Achilli: «Siamo al paradosso per cui un paese che tecnicamente non è ancora fallito perde comunque ogni sovranità economica e viene costretto a subire un piano di ristrutturazione non dissimile, per cogenza e contenuti, dai memorandum cui dovevano sottostare i paesi sottoposti al vecchio MES. In questo modo, inutile illudersi, momentaneamente la UE si rafforza, perché è riuscita a costruire un meccanismo disciplinare molto forte. Adesso possono anche vincere le elezioni i sovranisti, tanto saranno costretti comunque a sottostare ai diktat degli altri governi europei, se non vogliono perdere i fondi ed essere costretti a rimborsare in fretta e furia quelli già ottenuti».
Insomma, abbiamo sacrificato quel poco di democrazia che ci era rimasta in cambio di una manciata di miliardi che, se fossimo ancora un paese economicamente sovrano, non avremmo avuto nessun problema a mobilitare autonomamente (come stanno facendo buona parte dei paesi del mondo, inclusi diversi paesi emergenti e/o in via di sviluppo). E c’è chi la chiama una vittoria.