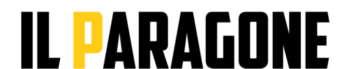di Luca Pinasco.
Il processo di “privatizzazione” è un meccanismo attraverso il quale la proprietà di un ente o di un azienda viene spostata dallo Stato al privato attraverso la cessione, in tutto o in parte, di quote di proprietà dello stesso. In Italia le privatizzazioni sono state avviate dal governo Amato con il decreto del 1992 n° 333 il quale ha trasformato in S.p.A le imprese strategiche di Stato tra cui IRI, ENI, INA ed ENEL, stessa sorte è successivamente toccata alle altre grandi aziende ed al sistema bancario.

Per mantenere poteri particolari di intervento e di veto a favore dello Stato, vista la delicatezza del settore in cui opera l’azienda privatizzata, si applicava l’istituto della “golden share“, notevolmente ridimensionato dal governo Monti il 9 marzo 2012 attraverso la rimozione di tale istituto dallo statuto delle società e la subordinazione dell’applicazione dei suoi contenuti ad un decreto del Presidente del Consiglio. Il processo di privatizzazione delle grandi aziende di Stato trovò inizialmente una fortissima opposizione nei partiti della Prima repubblica. La svolta si ebbe però con i processi di “Mani Pulite” che eliminarono di fatto i maggiori ostacoli politici. In teoria, la dottrina liberista ci dice che i vantaggi che si traggono dallo strumento della privatizzazione sono:
- Ridurre le spese di mantenimento e sviluppo da parte dello Stato.
- Rimediare all’inefficienza della gestione pubblica affidandola al privato che per sua intrinseca natura dovrebbe essere in ogni caso più efficiente dello Stato.
- Ridurre il debito pubblico mediante gli incassi derivanti dalla privatizzazione.
Riguardo i primi due punti c’è da dire però che l’aumento dell’efficienza del privato corrisponde inevitabilmente a tagli di rami d’azienda, tagli del personale, riduzione dei salari e peggioramento delle condizioni lavorative, flessibilizzazione dei contratti, operazioni che il proprietario pubblico spesso non effettua per motivi legati al mantenimento dei posti di lavoro o meramente al consenso elettorale. Ad esempio nel caso dell’ENI vi è stato un evidente calo occupazionale dal momento della gestione privata, dai 128.000 dipendenti del 1992 agli 80.000 del 2002 ai 31.000 odierni. E negli altri casi è andata pure peggio.

Per quanto riguarda il terzo punto, la crescita del rapporto debito pubblico/PIL con le privatizzazioni si è arrestata per qualche anno, ma nel medio termine ha ricominciato a crescere più di prima a causa di altri fattori macroeconomici quali: la scarsa crescita del PIL , la perdita delle leve di politica industriale, fiscale e monetaria, la crisi economica, le politiche di austerità e la scarsa consistenza dell’entrata derivante dalla privatizzazione rispetto allo stock del debito pubblico. Riguardo quest’ultimo punto bisogna aggiungere che dalla privatizzazione risulta uno stock in entrata (una quantità in ingresso statica, immediata ed unitaria) ma si rinuncia ai considerevoli dividendi, derivanti dalla proprietà di azioni delle società privatizzate, i quali avrebbero permesso di recuperare il ricavato della vendita delle stesse quote azionarie nel giro di qualche anno. Di contro, rispetto a quest’ ultima affermazione si potrebbe osservare che senza la privatizzazione, le grandi società pubbliche non avrebbero distribuito livelli così elevati di dividendi, avendo una gestione non orientata alla massimizzazione del profitto prima del 1995. Ma ciò porta a due considerazioni. La prima è che tali lauti dividendi sono stati distribuiti non allo Stato, bensì ai nuovi proprietari, spesso società finanziarie o fondi d’investimento esteri.
La seconda è quella di capire se a tale beneficio degli investitori è corrisposto un beneficio ai consumatori e alla collettività. A tal proposito, chiusa la stagione delle privatizzazioni, il 10 febbraio 2010 la Corte dei Conti ha pubblicato uno studio all’interno della quale elabora la propria analisi sull’efficacia di tale strumento. Il giudizio presenta evidenti note negative. Viene riscontrato che si è verificato un aumento della redditività delle aziende privatizzate e dei dividendi distribuiti, dovuto però, in specie nel secondo decennio “non alla maggiore efficienza quanto piuttosto all’incremento delle tariffe al quale non ha fatto seguito alcun progetto di investimento volto a migliorare i servizi offerti”. Senza considerare il gravissimo danno che la frammentazione dei campioni industriali italiani ha causato al sistema produttivo nella sua interezza, in quanto si è persa la dimensione di “grande impresa” capace di ottenere considerevoli economie di scala e competere nei settori strategici a livello globale.

Al di là delle ragioni economiche, vi sono ragioni strategiche altrettanto gravi. Con le privatizzazioni delle grandi aziende pubbliche viene meno una ulteriore sovranità in capo allo Stato, ovvero la possibilità di gestire la propria politica industriale. Oltretutto parliamo di aziende ad alto contenuto tecnologico, proprietarie di infrastrutture fondamentali alla vita del paese che operano in settori delicati come le telecomunicazioni, l’energia, le infrastrutture, la difesa e la loro cessione a soggetti stranieri crea inevitabilmente delle falle tanto nella difesa nazionale quanto nel nostro patrimonio di conoscenze, determinando cessioni di sovranità reale che difficilmente sarà recuperabile. Occorre prima comprendere le ragioni del declino industriale italiano per potervi porre rimedio. Purtroppo dobbiamo prendere atto che nessun partito esprime l’intenzione di fare passi indietro sulle privatizzazioni, ad eccezione di ITALEXIT.