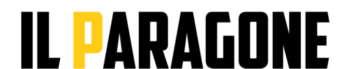di Savino Balzano.
Provocano una certa tenerezza quelli che hanno creduto alle lacrime della Bellanova: commuove quanto alcuni riescano ancora a crederci, riescano persino oggi – nonostante quante e quali ne abbiamo viste – a confidare in certi personaggi e ad abbandonarsi a certe narrazioni.
Allo stesso tempo si resta davvero esterrefatti: in tutta franchezza non si riesce nemmeno lontanamente a comprendere come si faccia a credere a una sindacalista che fino a pochi mesi fa sosteneva che l’art. 18 fosse una roba del secolo scorso. Si insomma, sia chiaro, a me farebbe specie sempre, ma ascoltarlo da una sindacalista comprenderete che smuove qualcosa dentro: una sensazione mista, tra gastrite e conati. Un po’ come se Bergoglio tirasse un bestemmione a San Pietro difronte Pietà di Michelangelo.
L’art. 18 è posto nella parte dello Statuto dei Lavoratori riservata alle libertà sindacali: il legislatore intendeva sostenere che non può esserci partecipazione, vita politica in azienda e nel Paese, senza tutele reali in capo ai lavoratori, senza proteggerli dall’arbitrio ritorsivo di qualche male intenzionato. Era un presidio di libertà e democrazia, un baluardo a difesa degli ultimi e dei più fragili, picconato e abbattuto dai governi Monti e Renzi. E come bersela, che oggi chi si rifà a quelle esperienze di governo possa commuoversi al pensiero di aver aiutato i fantasmi delle campagne d’Italia? È stupefacente che qualcuno mandi ancora giù una storiella del genere, sostenuta dalla retorica della “donna piegata dalle fatiche dei campi”: fateci il piacere!

Sono nato e cresciuto a Cerignola, in provincia di Foggia, un comune di 593 chilometri quadrati di estensione (considerate che Milano ne ha 181 e che Napoli ne ha 117): da noi l’agricoltura è tutto e scandisce l’esistenza di un intero territorio. Se la stagione è buona va bene a tutti, se va male allora siamo fregati tutti. A Cerignola è nato e cresciuto Giuseppe Di Vittorio, ci vuole altro che una Bellanova per impressionarci.
Me li ricordo i braccianti radunati avanti a Piazza Mercadante a “cercare la giornata”: oggi sono meno di qualche anno fa, ma ancora ce li trovi il pomeriggio. Ci si confronta su tutto e ci si informa ancora in strada sul prezzo di vendita delle olive, dell’uva, della frutta. Una ritualità consolidata ormai nei secoli, una liturgia sempre uguale a se stessa: un memoriale fatto di tradizione e mani callose annerite dalla terra. Cosa voglia dire noi lo sappiamo benissimo e non ce lo facciamo spiegare da nessuno.
Quella che si consuma nelle campagne del foggiano e in tutti i grandi scenari agricoli italiani dal nord al sud è una banalissima guerra tra poveri e risponde alle stesse drammatiche logiche che hanno colpito tutto il mondo del lavoro italiano: una drastica compressione della sfera dei diritti individuali dei lavoratori, che inevitabilmente si traduce in una impossibilità per gli stessi di partecipare e lottare. Diritti che la gabbia sistemica nella quale viviamo rende ormai tristemente insostenibili.

Chi sfrutta manodopera a nero, costringendo la gente a vivere in condizioni di profondissima indigenza in baraccopoli lerce e fatiscenti, riconoscendo salari da fame, sottoponendo donne e uomini a ritmi di lavoro davvero strazianti è un criminale senza scrupoli e andrebbe perseguito con la massima durezza. Va bene, ce lo siamo detto, ma basta dire questo per comprendere un fenomeno del genere? Assolutamente no.
Lavorare la terra oggi è un atto al limite dell’eroico. Viviamo in un sistema votato alla pressoché integrale liberalizzazione e i prodotti dei campi non sono più riconosciuti nel loro valore intrinseco. Arriva il raccolto e l’abbondanza non necessariamente è cosa buona: devi far presto, devi correre. Devi far presto perché solo il primo raccolto viene ben pagato: bisogna raccogliere la frutta in fretta e furia, cercando di camuffare quella acerba, per portarla il prima possibile agli ingrossi. Arrivatoci ti devi levare il cappello, e spesso ti trovi a confrontarti con arroganti palloni gonfiati che sanno benissimo di avere potere di vita e di morte sul tuo futuro e su quello della tua famiglia: spietati sceriffi del mercato.
Puoi decidere di consegnare la merce, oppure di lasciarla marcire sugli alberi. Tu la consegni, ma non te la pagano. Ti dicono che devono prima piazzarla e che ti faranno sapere, qualche settimana dopo. Tu torni sui campi e riprendi a raccogliere: e ti spacchi la schiena a caricare cassette di frutta che continui a portargli senza mai dimenticare di toglierti il cappello.

E quando arriva il momento della paga ti accorgi che una bella percentuale del peso è stato tarato perché la merce era “difettosa”, una metà del raccolto è stato venduto al settore industriale a 10 centesimi al chilo perché la domanda era quella che era e che l’invenduto, quintali e quintali di frutta pregni di sudore, è andato al macero perché la roba “della Spagna” o “dell’Africa” costava meno.
E questo si ripete ogni anno, anno dopo anno e stagione dopo stagione, e sono in molti ad abbandonare i terreni o a decidere di lasciare la frutta a marcire in campagna perché col raccolto non recuperano nemmeno il costo dell’acqua, dei concimi e dei pesticidi.
È lo Stato lo sa che le cose vanno in questo modo e lo sanno tutti che metà delle indennità di disoccupazione nel settore agricolo sono frutto di impicci e sotterfugi: a Roma lo sanno benissimo, ma pagano lo stesso perché se il settore collassa sono cavoli amari. Quando però torna di moda puntare il dito contro i terroni imbroglioni e scansafatiche e allora tutti si uniscono al coro degli ipocriti perché così tocca fare.

E sono in tanti, tantissimi ad accettare di lavorare in nero e manco se la prendono col padrone perché lo sanno che quello a fine mese spesso non ci arriva e che non ha manco gli occhi per piangere. E poco male se gli italiani lasciano i campi, tanto ci sono gli immigrati che quelli nelle baracche si accontentano e gli dai pochi euro al giorno: entrano in massa grazie ai perbenisti del politicamente corretto e restano sine die nel circolo della clandestinità degli amanti del rigore. Il sistema è perfetto: lo sanno tutti che funziona così, sono i figli indesiderati delle “politiche facili e immediate”, il resto sono palle.
Se giri per i campi del foggiano li vedi i contadini guardare il cielo con lo stesso terrore che hanno gli aquilani quando ricordano il terremoto: pensano alla grandine, che se arriva ti mette in ginocchio, ma dalla quale non ti puoi difendere perché il costo delle assicurazioni è altissimo e con quel che si guadagna possono avercela solo i pesci più grossi.
È la globalizzazione, è il libero mercato, è la circolazione delle merci e dei capitali, bellezza, e i contadini possono continuare a fare i cafoni di Fontamara.
In tutto questo il grande assente è sempre lo stesso, il fantasma che oggi più che mai lascia un insopportabile e soffocante senso di vuoto, lo Stato.

O, meglio, lo Stato che vorremmo noi, quello della Costituzione: uno Stato diverso da quello che si affanna a difendere i più forti, i più potenti, i più ingordi, quelli che hanno la sede legale in Olanda. Noi vorremmo uno Stato che tuteli i più deboli, gli emarginati, gli ultimi: che garantisca dignità all’agricoltura e a chi vi si fa il mazzo sotto il sole, che riconosca buone condizioni di lavoro a chi vi presta la propria opera, che protegga la ricchezza di un Paese e di tutti i suoi territori dallo sciacallaggio delle tempeste liberiste al quale siamo ormai da tempo sottoposti.
Questo ci vorrebbe e le lacrime della Bellanova non attribuiscono nemmeno lontanamente allo Stato il ruolo che dovrebbe ricoprire: una sanatoria come quella presentata frignando in conferenza stampa è una lavata di mani dinanzi a una realtà infinitamente più complessa e sofferta, una voltata di spalle dinanzi a un popolo che inesorabilmente sarà costretto a risalire il suo Golgota ancora per molto.