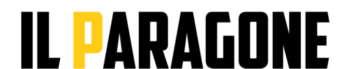di Ludovico Vicino.
Che fine ha fatto la potenza di fuoco? di Ludovico Vicino
La parabola dei quattrocento miliardi paventati dal decreto Liquidità è l’epitome della straziante farsa che il nostro Paese vive da vent’anni a questa parte. Farebbe ridere se non facesse piangere.
Annunciato trionfalmente da Conte come “un intervento senza precedenti” che avrebbe irrorato di liquidità cittadini e imprese, a un mese e mezzo dal proclama il tanto atteso tsunami risulta ancora non pervenuto. Proviamo dunque a capire cosa sia andato storto e come mai, nonostante la decantata “potenza di fuoco”, il tessuto produttivo del Paese giorno dopo giorno si scopra sempre più inaridito.

Innanzitutto occorre tenere a mente che i famosi quattrocento miliardi sono tutt’altro che denaro fresco da iniettare nell’economia reale. Si tratta infatti di garanzie che lo Stato offre alla banche in caso di insolvenza dei debitori stritolati dalla crisi, cosa che – va da sé – tutela gli istituti di credito ma non protegge in alcun modo le imprese dal rischio di fallimento. Eh già, mentre in tutto il mondo i Governi mettono in campo finanziamenti a fondo perduto per far fronte alle conseguenze della pandemia, qui in Italia, nonostante le misure di lockdown siano state tra le più draconiane, l’unica via che viene prospettata a chi annaspa per rimanere a galla è quella dell’indebitamento. E visto che la sacrosanta richiesta di un anno bianco fiscale inoltrata alla Presidenza del Consiglio è stata amabilmente rispedita al mittente perché “non ce lo possiamo permettere”, è pacifico ritenere che i prestiti concessi serviranno per lo più a pagare le tasse.
Ma non è finita qui. Com’era facile prevedere, in queste settimane le banche non hanno esattamente steso un tappeto rosso a tutti coloro che entravano a chiedere un finanziamento. Anzi, a dirla tutta, sono davvero pochi i fortunati che sono riusciti a superare senza intoppi tutte le resistenze emerse per ottenere l’accesso al credito. D’altronde non poteva esser diversamente, per tutta una serie di ragioni. In primis, il decreto Liquidità ha predisposto un imponente iter burocratico disseminato di una miriade di certificazioni e attestati indispensabili per arrivare a sottoscrivere un fido coperto da garanzie statali. In secondo luogo, solo una parte di queste garanzie arrivano a coprire il 100% degli importi concessi, quindi, di fronte all’incombenza di una crisi economica che non ha precedenti nella storia repubblicana, non è strano che le banche ci pensino due volte prima di allentare i cordoni della borsa.

E poi c’è un altro motivo di questa ritrosia, che è poi il più semplice di tutti: le banche non vogliono rischiare di trovarsi con il cerino in mano.
Attualmente infatti, dei quattrocento miliardi di garanzie promesse, ne sono stati allocati per le coperture ben… Tre. Non trecento, non trenta, ma tre. Gli istituti di credito non si fidano dello Stato, e il guaio è che potrebbero non avere tutti i torti. La profezia MESsianica che si sta delineando tra Roma e Bruxelles non lascia ben sperare e le esternazioni di Conte rappresentano in modo plastico tutta la minorità di uno Stato che ha scelto di condannarsi all’inaffidabilità finanziaria. Nell’infelice uscita in cui il premier chiedeva alle banche “un atto d’amore” è racchiuso il dramma di uno Stato che, privatosi della possibilità di battere moneta, cerca di arrabattarsi supplicando delle istituzioni private di crearla al suo posto. Trascurando il piccolo dettaglio che la moneta frutto dell’attività creditizia, prima o poi, va restituita.
Anche se è triste dobbiamo esserne consapevoli perché questa emergenza l’ha reso oscenamente chiaro: se non ribaltiamo il tavolo, siamo destinati a diventare uno Stato con la minuscola. Che, per l’appunto, è stato.