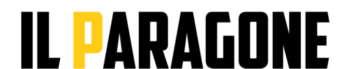di Gianluigi Paragone
Se è vero che il coronavirus è allo stesso tempo un virus della globalizzazione e nella globalizzazione, è altrettanto vero che il solito vecchio vizio – o il solito vecchio male – italiano del pressappochismo ci ha proiettati in vetta alle nazioni occidentali con più casi di contagio. Pertanto ci dobbiamo aspettare una escalation di casi da affrontare. Del perché siamo arrivati a questa situazione emergenziale non so dirvi (anche se mi piacerebbe che qualcuno al governo cominciasse a ripensare alcune mosse in termini più critici); rispetto al cosa succederà adesso invece vorrei condividere alcune riflessioni.

Pensare che la collettività possa non vivere momenti di intensa preoccupazione o addirittura situazioni di panico è illusorio: tutti e sottolineo tutti i media sono “accesi” ininterrottamente sulla questione, alimentando di per sé la preoccupazione con dirette dai luoghi più a rischio, dai presidi ospedalieri, dai palazzi delle istituzioni che diramano bollettini e annunci che di ora in ora si fanno sempre più restringenti della libertà di movimento di ciascuno di noi. Per non dire della corsa a dar voce all’esperto o a inseguire la gente comune per sapere quanto sia preoccupata. Poi ci sono i politici e i giornalisti, altalenanti tra il commentatare il flusso di notizie e il voler rassicurare e rasserenare come a dire che non bisogna farsi prendere dal panico.

È chiaro che questo inarrestabile circuito si gonfierà di giorno in giorno e così anche il dono della ragionevolezza segnerà il passo a favore della emotività, della preoccupazione, dell’allarmismo e persino della esagerazione. Mi segnalano fotografie già “virali” (beffa semantica…) in rete di supermercati presi d’assalto per fare scorte di cibo e altro genere come se fossimo sotto bombardamento. Altro che esaurimento scorte delle mascherine, tra poco registreremo crisi di isteria collettiva per accaparrarsi la roba che resta sugli scaffali. “Stiamo esagerando?”, si domanda qualcuno in un esercizio di stile inutile perché siamo ormai dentro la sfera dell’emotività e nella insicurezza.

Il continuo aggiornamento della situazione non farà che consolidare questa specie di trance collettiva, di aumentare la fame di informazioni e quindi di angoscia, di ansia. Il cui sbocco naturale non potrà che essere il presidio sanitario e ospedaliero. E qui arrivo ad un tema doloroso perché mi riporta ai soliti temi di cui tratto: la spesa pubblica. L’emergenza del coronavirus ci farà toccare con mano la gravità dei tagli nel settore sanitario pubblico compiuti negli ultimi decenni. Il sistema sanitario sarà sottoposto a uno stress crescente di situazioni (reali o percepite); i progressivi tagli di presìdi e soprattutto l’assoluta mancanza di programmazione di reclutamento e di formazione del personale medico complicheranno non poco la gestione dell’emergenza.

L’impiego della Sanità Militare non può essere la carta jolly vincente, perchè anche quella è stata maltrattata dalle scelte politiche; eppure per numero di personale e per strutture presenti sul territorio (per lo più chiuse e fatiscenti) avrebbe potuto essere parte di quel servizio sanitario cui nessun Paese responsabile rinuncerebbe. Invece, la situazione è da decenni al limite del sostenibile tanto che nei picchi influenzali o nelle settimane estive di grande afa, il personale ospedaliero si trovava a dover gestire i turni con enormi sacrifici. Stavolta la cronicità di deficit di risorse umane (allargando a tutto il personale che lavora nelle strutture, da quello medico all’infermieristico passando per gli addetti ai servizi), la privatizzazione di alcuni servizi come i laboratori analisi e le progressive politiche di riorganizzazione degli spazi saranno ancor più evidenti proprio perché quella paura collettiva, che già oggi spinge a far scorte di cibo, si riverserà sulla già martoriata sanità. Il cui servizio è stato impoverito da tagli enormi imposti dalla logica rigorista del pareggio di bilancio e da una certa narrazione per cui tutto ciò che è pubblico non funziona.

Pagheremo inoltre tutte le mancanze sulla programmazione del personale (erano anni che secondo me andava fatta una riflessione sulla politica del numero chiuso nelle facoltà di Medicina, così come sulla scarsità assoluta delle borse di studio), pagheremo le scelte su come abbiamo svilito la ricerca e il ruolo dei ricercatori e pagheremo la fuga proprio dai settori sanitario-ospedalieri di personale stanco di essere sfruttato, malpagato e pure umiliato dai soliti giochi di primari, direttori e baroni universitari vari. Ecco, l’emergenza del coronavirus e la frenesia del suo racconto sui media sarà lo specchio per osservare la nostra sanità italiana, la cui sostanziale tenuta è sulle spalle di tanti professionisti per bene che ogni giorno, nonostante tutto, tengono in piedi il servizio sanitario nazionale.
Questo editoriale è stato pubblicato su Il Tempo del 24 febbraio 2020.
Ti potrebbe interessare anche: Tasse e affitti alle stelle, burocrazia e miopia politica: 70mila negozi chiusi in 10 anni