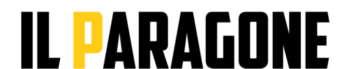Titolo sacrosanto quello di ieri: le donne nel recinto. Bastava guardare le foto e ascoltare i racconti per accorgersi che la fine del Ramadan non coincide, nel mondo islamico, con la fine della separazione tra uomo e donna. Hai voglia – come mi capita di sentire in alcune trasmissioni – che l’Islam tiene le donne sul palmo di mano, che le donne portano il velo per scelta e per rispetto verso il Profeta, e roba di questo tipo. Macché, basta osservare e le immagini parlano chiaro: ritraggono una “ghettizzazione” rigida tra uomini e donne, con gli uomini messi negli spazi migliori mentre le donne vengono recintate e confinate negli spazi laterali. Ripeto, basta guardare. A Turbigo, perché nessuno ha voluto richiamare al rispetto della pari dignità? Paura di rovinare il clima? O semplice ritrosia?

A questo punto vale la pena domandarsi se nel recinto, in un certo senso, non ci stiamo finendo anche noi, spinti da quella idea di dialogo che odora di senso di colpa o semplicemente di un non meglio identificato sentimento di sudditanza culturale che muove i presidi a chiudere le scuole e agli imprenditori di fermare le fabbriche “perché tanto la maggioranza è islamica” e quindi le aule si svuotano e i processi produttivi si fermano. Lo stesso fanno quei sacerdoti che si sostituiscono ai sindaci per concedere spazi di preghiera perché “nessuno deve sentirsi straniero ed è un momento di meravigliosa convivenza”.

Ma che razza di discorsi sono? Ci si ferma perché sono la maggioranza e ci si apre perché è una meravigliosa convivenza. Non mi risulta che nei paesi islamici siano rispettate parimenti la convivenza e le altre minoranze religiose. Anzi, mi sembra che in giro per il mondo i cristiani non se la passano affatto bene. Il Ramadan è una festa profondamente religiosa e identitaria, un momento intenso che caratterizza una comunità granitica. Che non è la nostra. La maggioranza degli italiani è indifferente per colpa di un relativismo culturale che negli anni non è stato analizzato. Ne parlava l’allora cardinal Biffi ma niente; eppure l’allora cardinale parlava sulla scia del primo “strappo” compiuto dal monsignor Maggiolini e in seguito dall’allora prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, cardinale Joseph Ratzinger, nella dichiarazione ‘Dominus Iesus’ dell’agosto 2000. In questo testo si rivendicava un’identità cattolica forte, capace di reggere l’urto non solo con la secolarizzazione ma anche con una religione come l’Islam che si manifesta come un temibile concorrente sul ‘mercato dei beni religiosi’. La discussione è ancora ferma lì.
Ne scrissero due splendide donne di cultura, Oriana Fallaci e Ida Magli, delle quali ho ripreso i libri: inascoltate e isolate. È questo il recinto invisibile che ci stiamo costruendo sottovalutando l’importanza di parole quali radici e identità. Rivendicare l’identità significa non brancolare nel buio in una epoca profondamente segnata dalla cultura woke, dal rovesciamento di valori importanti per proiettarci in un mondo che, guarda caso, nei social diventa il solo mondo di riferimento. Quella stessa Chiesa che apre ad altre comunità religiose non difende le feste patronali che ormai si perdono sempre per non disturbare una società multietnica! Lo stesso vale per i sindaci impauriti se affermano le radici di un santo che magari riconduce al nome della città o del paese.
Così, le stesse persone che tolgono i generi maschile e femminile per non ferire nessuno, che parlano di fluidità gender, che affogano le radici in un relativismo che ormai è persino andato oltre ed è puro menefreghismo, quelle stesse persone stanno zitte di fronte a chi risponde alle nostre aperture con la separazione tra uomo e donna in luoghi senza pari dignità.