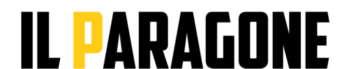di Thomas Fazi.
Che moltissimi imprenditori piccoli e medi vedano oggi lo Stato come un nemico è un dato di fatto. È un sentimento comprensibile, dato che le loro interazioni quotidiane con lo Stato sono fatte perlopiù di tasse e burocrazia. Ma gli imprenditori commettono un errore madornale nell’identificare il nemico nello Stato tout court piuttosto nelle specifiche politiche portate avanti da questo Stato. Per il semplice fatto che, se è vero che oggi lo Stato è causa di molti dei loro mali, è altresì vero che solo lo Stato può risollevare le loro sorti. La soluzione, tuttavia, non consiste – come pensano probabilmente molti imprenditori, che se lo sentono ripetere tutti i giorni da anni dalle veline liberiste che affollano le tribune politiche, nonché da praticamente tutti i partiti politici dell’arco parlamentare – nel “lasciarli lavorare” (o laissez-faire, come direbbero i francesi), cioè in una semplice riduzione dell’opprimente interferenza dello Stato nella vita economica delle imprese. L’idea che le tasse e la burocrazia rappresentino il principale freno dell’economia italiana, e che basterebbe levare queste di mezzo perché le imprese tornino a volare – come ama ripetere Salvini –, è seducente (perché intuitiva) quanto sbagliata.

Ora, è evidente che tutte le imprese beneficerebbero da una riduzione delle tasse e/o da una semplificazione della burocrazia. Questo lo capirebbe anche un bambino. L’errore sta nel considerare queste misure sufficienti per rilanciare l’economia. Basti pensare che, secondo i dati della Banca mondiale, la pressione fiscale sulle imprese negli ultimi otto anni è scesa di ben nove punti, dal 68 al 59 per cento; nello stesso periodo, nella classifica internazionale “Doing Business”, redatta sempre dalla Banca mondiale, che calcola la “facilità di fare impresa”, l’Italia è passata dal 78esimo al 58esimo posto. Qualcuno ha notato grandi balzi in avanti nell’economia nel periodo in questione? Appunto.
La verità è che il mercato, da sé, non è assolutamente in grado di assicurare la crescita e lo sviluppo di un paese; al contrario, il tessuto produttivo di una nazione può fiorire solo laddove lo Stato intervenga attivamente per creare un circolo economico virtuoso, soprattutto nel bel mezzo di una devastante crisi economica come quella che stiamo attraversando da mesi (anzi, da anni). Tanto per cominciare, solo lo Stato, in quanto attore “esterno” al mercato, può sostenere, attraverso la politica di bilancio e in particolare la spesa pubblica (soprattutto quella in disavanzo), quella variabile fondamentale per la crescita e lo sviluppo del tessuto produttivo che è la cosiddetta “domanda aggregata”, cioè la quantità di beni e servizi complessivamente richiesta dai soggetti economici. Questo è particolarmente vero in un momento di crisi, quando il settore privato (banche, imprese e famiglie) tende inevitabilmente a ridurre la propria spesa/domanda. Ed è ancor più vero per quei paesi come il nostro in cui la crescita è tradizionalmente trainata dalla domanda interna: basti pensare che la stragrande maggioranza della micro, piccola e media imprenditoria italiana (un buon 75-80 per cento delle imprese) vive di domanda interna. In questi casi, è praticamente d’obbligo un bilancio pubblico primario (cioè al netto della spesa per interessi sul debito) in disavanzo, in cui, cioè, il denaro immesso nell’economia reale dallo Stato attraverso la spesa pubblica sia superiore al denaro sottratto all’economia per mezzo delle tasse.
Va da sé, però, che per fare questo – cioè per poter sostenere l’economia attraverso la politica di bilancio e i disavanzi pubblici in particolare – lo Stato deve controllare le leve dell’economia, a partire da quella monetaria, da cui dipende la capacità di uno Stato di gestire il finanziamento del deficit/debito pubblico (attraverso il controllo dei tassi di interesse e la monetizzazione, all’occorrenza, del deficit/debito). Che è esattamente quello a cui abbiamo rinunciato aderendo all’euro, mettendo la nostra politica di bilancio nelle mani di chi controlla l’emissione di moneta – la BCE – e dei mercati finanziari. Questo è il motivo per cui l’Italia, negli ultimi vent’anni, si è vista costretta, per una scellerata scelta delle sue classi dirigenti, a perseguire una politica di «austerità fiscale permanente», determinando così quella «carenza cronica di domanda interna» che è alla radice della pluridecennale stagnazione economica del paese e della conseguente crisi della nostra struttura produttiva. E che oggi impedisce allo Stato di rimettere in moto l’economia, anche solo attraverso un taglio delle tasse (perché comporterebbe un incremento significativo del deficit pubblico), che non sarebbe comunque risolutivo, come detto.

Possiamo dunque rilevare un interessante paradosso: l’“oppressione” statale denunciata da molti imprenditori è in realtà il sintomo di uno Stato estremamente debole, privato del controllo delle principali leve di comando dell’economia, e dunque costretto a perseguire politiche eterodirette strutturalmente depressive. Ne consegue che ciò di cui avrebbero bisogno gli stessi imprenditori, oltre che ovviamente i lavoratori, non è “meno Stato” ma “più Stato”: uno Stato cioè che recuperi la piena sovranità politica e il pieno controllo sulla politica economica, conditio sine qua non per «spezza[re] la spirale infernale di deflazione, disoccupazione e desertificazione industriale» e per garantire un futuro di prosperità e benessere per l’Italia, come ammoniva un recente editoriale di Limes. Peccato che tra i principali sostenitori dell’architettura economica europea figuri proprio Confindustria, che in teoria dovrebbe difendere gli interessi delle imprese italiane, ma che evidentemente ha a cuore solo «gli interessi europeistici di una certa imprenditoria, la grande imprenditoria finanziarizzata e multinazionale (anche se forse sarebbe meglio dire antinazionale), che punta tutto sulle esportazioni e pochissimo sul mercato regolato dalla domanda interna».
La politica di bilancio, però, non è l’unico strumento attraverso il quale lo Stato può sostenere il tessuto produttivo di un paese. Il caso italiano rappresenta un esempio da manuale di come l’impresa privata, soprattutto quella piccola e media, possa beneficiare della presenza di un sistema di grandi imprese pubbliche. Come è noto, le imprese pubbliche, la maggior parte delle quali facenti capo all’IRI (Istituto per la ricostruzione industriale, creato nel 1933), furono uno dei pilastri di quel modello di “economia mista” pubblico-privata che caratterizzò l’economia italiana nel periodo che va dal secondo dopoguerra fino alla fine degli anni Ottanta, e che fece dell’Italia, per oltre trent’anni, il paese d’Europa con la più elevata crescita media. A questo successo – dei cui frutti godette ovviamente anche l’impresa privata – contribuirono in modo determinante proprio le imprese pubbliche.
Come spiega l’economista Ugo Pagano dell’Università di Siena, il sistema capitalistico privato italiano – per diverse ragioni inerenti alla peculiare natura del capitalismo italiano, non ultimo la natura familistica e “dinastica” di quest’ultimo, ovverosia l’assenza di separazione tra proprietà e controllo delle imprese – è sempre stato caratterizzato da un «patologico nanismo», per riprendere un’espressione di Marcello De Cecco: sarebbe a dire che, sebbene le piccole e medie imprese abbiano sempre rappresentato, da un lato, un punto di forza dell’economia italiana, dall’altro queste hanno sempre faticato a trasformarsi in grandi imprese, le quali tendono a investire di più in ricerca e sviluppo e dunque a essere più innovative (e a esprimere una maggiore domanda di lavoro qualificato). A supplire a questa debolezza strutturale della nostra economia ci pensarono, nel dopoguerra, proprio le grandi imprese pubbliche.
Scrive Pagano: «Solo grazie a questa complementarità fra sistema pubblico e privato fu possibile fare diventare l’economia italiana uno dei centri importanti del sistema capitalistico mondiale. La formula italiana dell’ente pubblico, che caratterizzava l’IRI e l’Eni, era stata l’artefice del cosiddetto miracolo italiano. Essa costituiva una formula originale che permetteva a questi enti pubblici, dotati di autonomia amministrativa, di perseguire il fine dello sviluppo industriale mediante partecipazioni azionarie maggioritarie». De Cecco osservava come:
“Fino agli anni settanta l’industria pubblica viene ammirata e presa da esempio da altri paesi; esprime figure di manager, imprenditori di grandi qualità, quali Oscar Sinigallia, Enrico Mattei, Guglielmo Reiss Romoli. Per molti anni il modello italiano di economia mista funziona e l’imprenditore pubblico è protagonista di brillanti imprese; ad esso si deve la struttura industriale innovativa nei settori della energia (Eni), la costruzione delle autostrade, le reti telefoniche e del gas, la diffusione della energia elettrica in ogni parte d’Italia, lo sviluppo della siderurgia a ciclo continuo“.

In altre parole, notano Aldo Barba e Massimo Pivetti, lo sviluppo dell’Italia nel dopoguerra, come quello di altri paesi, dovette molto al fatto che le imprese pubbliche, proprio perché non subordinate alla massimizzazione del profitto di breve periodo ma ad obiettivi sociali e nazionali di più lungo periodo, si fecero carico, «in tutti i settori di maggior rilievo, di grande parte degli investimenti ad alta intensità di capitale e particolarmente rischiosi che gli imprenditori privati non avevano trovato conveniente effettuare e che era tuttavia necessario intraprendere per tenere il passo delle nazioni più industrializzate». A questo va aggiunto che gli investimenti pubblici, e più in generale l’arricchimento della matrice industriale e infrastrutturale italiana, determinavano un significativo indotto “a cascata” su molte imprese private piccole e medie, facendo da volano anche agli investimenti privati.
Date queste premesse, non sorprende che lo smantellamento dell’apparato industriale pubblico italiano – nel corso degli anni Novanta, su impulso del nuovo regime economico post-Maastricht, furono completamente privatizzate pressoché tutte le società del gruppo IRI, che sarebbe poi stato liquidato nella sua interezza nel 2002 –, lungi dall’aprire una fase nuova in cui l’iniziativa privata si è assunta il ruolo di promotrice del processo di sviluppo – perché finalmente libera dall’oppressione della politica e dunque capace di sprigionare quegli “istinti animali” del capitalismo troppo a lungo repressi, come recitava la vulgata–, abbia invece finito per impoverire la struttura industriale italiana nel suo complesso, a danno anche della piccola e media impresa privata.
Oggi sappiamo che non si è materializzata nessuna delle magnifiche e progressive sorti delle privatizzazioni presagite da Prodi e dagli altri: maggiore dinamicità, migliori prestazioni, riduzione dei costi dei servizi, ripresa dell’occupazione, aumento della produttività ecc. Al contrario, come ha affermato Pierluigi Ciocca, vicedirettore generale della Banca d’Italia dal 1995 al 2006, dal 1992 (anno in cui è iniziato lo smantellamento dell’IRI) «l’economia italiana ha conosciuto la peggiore performance dal tempo di Cavour. Lo stock di capitale si è eroso. Il progresso tecnico è svanito […]. È stato smentito chi aveva pensato che la sostituzione dell’impresa privata all’impresa pubblica desse risultati migliori».
Le imprese privatizzate, la maggior parte delle quali sono finite nelle mani di spregiudicati oligarchi locali privi di qualunque visione imprenditoriale, non hanno solo visto peggiorare drasticamente il livello dei servizi – basti pensare al caso drammatico di Autostrade –, ma hanno anche smesso di crescere e di investire. Nel mentre la produttività, che dal 1981 al 1995 si era situata in linea con la media europea, è crollata. Le privatizzazioni, scrive Pagano, hanno anche «ridotto la domanda di lavoro qualificato […] spingendo gli italiani a cercare all’estero quel tipo di lavori qualificati che le piccole imprese italiane non erano in grado di offrire» e contribuendo così «ad aumentare la cosiddetta fuga dei cervelli».
Il risultato delle privatizzazioni, in altre parole, è stato di accelerare quel processo di deindustrializzazione e di declino produttivo-competitivo – e i relativi effetti su produttività, composizione del lavoro, forme retributive ecc. – che i fautori delle privatizzazioni (Draghi, Ciampi, Prodi ecc.) auspicavano di voler arrestare con le privatizzazioni stesse. Appare chiaro, insomma, che «[u]na delle importanti cause del declino italiano può essere fatta risalire all’abbandono del suo modello di capitalismo, basato sulle imprese pubbliche», dice Pagano. A questo proposito, così scriveva De Cecco nel 2014:
“Se si voleva distruggere l’industria italiana ci sono riusciti. Gli studi della Banca d’Italia dimostrano che al tempo l’industria di Stato faceva ricerca per tutto il sistema economico italiano. Dopo le privatizzazioni, chi ha preso il posto dell’IRI, ad esempio, non l’ha voluta fare. Siamo rimasti senza un altro pilastro importante della politica industriale, mentre si continuano a fare solenni discorsi sull’istruzione, sulla ricerca o la cultura. In questi anni è stato distrutto tutto. Su questo non ci piove”.
Paradossalmente, proprio le privatizzazioni hanno finito con il confermare le carenze del settore privato e i vantaggi relativi delle imprese pubbliche. Di fatto, le uniche grandi imprese che in questi anni hanno continuare a crescere, innovare e investire sono quelle che, pur essendo state trasformate in società per azioni, sono rimaste sotto il controllo dello Stato. Quest’ultimo, infatti, è ancora l’azionista di riferimento delle due (di gran lunga) più grandi imprese italiane (Eni ed Enel), e sono a controllo pubblico sette fra le prime tredici imprese dell’industria e servizi, non controllate dall’estero, che operano in Italia. Se escludiamo banche e assicurazioni, il numero di partecipate pubbliche sale a cinque su sette tra le aziende con i maggiori fatturati. I grandi gruppi di produzione ad alto valore aggiunto tecnologico presenti nel listino di Piazza Affari sono, con poche eccezioni, tutte in parte di proprietà dello Stato: Eni, Leonardo, Fincantieri, Saipem, Snam, STMicroelectronics. Insomma, «anche dopo gli anni Novanta lo Stato imprenditore è riuscito a limitare i danni del nanismo delle nostre imprese private», commenta Pagano.

Alla luce di ciò, fanno sorridere gli allarmi lanciati da Confindustria in questi mesi sulle terribili insidie che si celerebbero dietro l’ingresso dello Stato nelle imprese, tema tornato all’ordine del giorno (non solo in Italia) a seguito della crisi determinata dalla pandemia globale, e che rappresenterebbe chissà quale minaccia per “la libertà d’impresa” e l’apparato produttivo del paese. Al contrario, dovrebbe essere ormai chiaro che la creazione di una nuova IRI, che si faccia carico innanzitutto di effettuare quegli investimenti in ricerca e sviluppo che i privati non vogliono o non sono in grado di effettuare, trainando così il paese fuori dalla “trappola della mediocrità” nella quale l’industria italiana è incastrata da vent’anni, sarebbe nell’interesse non solo del paese nel suo complesso, ma anche e soprattutto delle piccole e medie imprese private, esattamente come è stato fino agli anni Novanta.
Con la differenza che, laddove nel 1933 il compito dell’IRI si limitò a subentrare nella gestione di grandi imprese fallite, oggi molte di queste andrebbero create da zero, allargando la base produttiva del paese in settori avanzati in cui oggi siamo drammaticamente carenti. Come scriveva Ciocca qualche anno fa: «Mentre nel 1933 lo Stato subentrò in aziende che c’erano, oggi lo Stato dovrebbe creare le grandi imprese che non ci sono. Ma la questione si imporrebbe qualora i privati mancassero di assicurare al Paese una manifattura competitiva perché capace di produttività diffusa».
È una sfida ambiziosa, ma deve confortarci il fatto che stiamo parlando di un modello, quello dell’IRI e della cosiddetta “economia mista” pubblico-privata, in cui per decenni siamo stati un modello per il mondo intero. E qui arriviamo a quello che è forse il paradosso dei paradossi: quel “modello italiano”, fondato sulla commistione fra grande impresa (e banca) pubblica e impresa privata, che gli ascari della seconda Repubblica hanno smantellato quasi per intero con la scusa che trattavisi di un modello vetusto e retrogrado, è stato invece parzialmente preservato in pressoché tutte le altre economie europee, basti pensare alla Francia e alla Germania, e oggi il tema dello “Stato imprenditore” è oggetto di un rinnovato interesse a livello mondiale, alla luce dell’evidente fallimento del paradigma neoliberale. Insomma, a quanto pare noi italiani non stavamo indietro, stavamo troppo avanti. Quando lo capiremo – e quando i nostri imprenditori (ma anche i lavoratori) capiranno che lo Stato è un loro (potenziale) alleato, non un nemico – saremo finalmente pronti per ritornare al futuro.