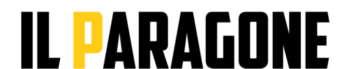di Thomas Fazi
Sta facendo discutere l’ultima uscita di Alberto Bagnai, che pochi giorni fa al Senato ha dichiarato che la Germania, per mezzo di strumenti quali il Recovery Fund, sta perseguendo un obiettivo non dissimile, nella sostanza, da quello di Hitler: ovverosia l’unificazione economica e politica del continente sotto il comando della Germania. Ad alcuni l’accostamento potrebbe sembrare assurdo: cosa potrebbe esservi di più lontano dal nazionalismo violento del terzo Reich dell’europeismo, per quanto magari autointeressato, della cancelliera Angela Merkel?
In verità, come spiego nel mio libro Sovranità o barbarie, l’affermazione del senatore non è così lontana dalla realtà.
È opinione comune che il moderno pensiero federalista nasca dalle ceneri della seconda guerra mondiale. Ma le teorie federaliste risalgono a ben prima del conflitto mondiale e persino lo stesso federalismo “antifascista” di Spinelli presenta inquietanti elementi di contiguità con le teorie che ispirarono quel conflitto e in antitesi alle quali, secondo la vulgata, si sarebbe sviluppato il pensiero federalista.

L’ideologia europeista, antisovranista e sovranazionalista – e il sogno dell’unificazione economico-politica del continente (sotto il dominio della Germania) – erano infatti aspetti centrali della stessa filosofia nazifascista, nelle sue molteplici varianti, nonché della propaganda hitleriana.
Come scrive lo storico inglese John Laughland, autore di un corposo volume sul tema, «non solo i nazisti, ma anche i fascisti e i loro collaboratori in giro per l’Europa, hanno fatto ampio uso dell’ideologia federalista ed europeista per giustificare le loro aggressioni». Ciò potrebbe meravigliare. È opinione comune, infatti, che i nazifascisti, in quanto ultrasciovinisti e imperialisti, esaltassero lo Stato-nazione e la sovranità nazionale; in verità, osserva Laughland, «essi nutrivano una profonda avversione per la sovranità nazionale; non solo, come può sembrare ovvio, per quella delle altre nazioni, ma per il concetto stesso».
Tanto tra i liberali quanto tra i fascisti dell’epoca era infatti diffusa l’idea che la crescente interdipendenza economica tra paesi, il progresso tecnologico (soprattutto nel campo delle telecomunicazioni) e lo sviluppo di nuove reti di trasporto rendessero anacronistico il concetto di sovranità nazionale (vi suona familiare?).

La tecnologia dei trasporti e delle telecomunicazioni sta accorciando le distanze tra i popoli – diceva Goebbels nel 1940 – e questo condurrà inevitabilmente all’integrazione europea.
Come scriveva Camillo Pellizzi, uno dei principali intellettuali fascisti dell’epoca: «Nessuna singola nazione europea può sperare oggi, e ancor meno in futuro, di competere nelle questioni militari, economiche o culturali con le grandi forze che stanno nascendo o già esistono all’infuori dell’Europa». Per questa ragione sia i fascisti che i nazisti ritenevano che «lo sviluppo verso unità più grandi» fosse economicamente inevitabile.
Nel 1943 lo stesso Hitler dichiarò che «il disordine delle piccole nazioni» e «l’anacronistica divisione dell’Europa in singoli Stati»andavano liquidati. Lo scopo della lotta nazista era quello di creare un’Europa unita. A tal fine, i singoli paesi europei dovevano essere disposti «a subordinare i propri interessi a quelli della Comunità europea»: parola di Walther Funk, ministro per gli Affari economici del terzo Reich dal 1937 al 1945.

L’idea, cara tanto ai liberali quanto ai fascisti dell’epoca, secondo cui nell’epoca moderna gli Stati nazionali erano destinati a essere rimpiazzati (o schiacciati) dalle “macroregioni” deve molto alle teorie del celebre economista tedesco Friedrich List.
Quest’ultimo teorizzava che per resistere alle pressioni esercitate dalle potenze esterne e per competere adeguatamente con esse sui mercati mondiali, l’Europa doveva fondersi in un’unica unità economica, sotto la “direzione” della Germania. Le teorie di List furono poi riprese dai primi teorici geopolitici di inizio Novecento (tedeschi anch’essi) – come Karl Haushofer e Carl Schmitt –, che elaborarono i concetti di Lebensraum (“spazio vitale”) e di Grossraum (“grande spazio”), poi ripresi dai nazisti, che proponevano di riportare la Germania alla sua centralità mondiale, dotandola appunto di un suo “spazio vitale” a livello continentale. A tal fine, come detto, i nazisti proponevano la creazione di un nuovo ordine economico che ponesse fine, una volta per tutte, alla “balcanizzazione economica dell’Europa”.

Qui le similitudini tra l’europeismo nazifascista e quello contemporaneo si fanno veramente sorprendenti. I nazisti, infatti, elaborarono dei piani di integrazione/unificazione economica dell’Europa incredibilmente dettagliati che presentano sorprendenti affinità con l’Unione europea dei giorni nostri. Nel 1940, per esempio, Hermann Göring, presidente del Reichstag, presentò un piano dettagliato per «l’unificazione economica su vasta scala dell’Europa». Esso includeva un’unione doganale, un mercato unico e l’istituzione di cambi fissi tra paesi, «nell’ottica della creazione di un’unione monetaria europea».
L’unificazione monetaria giocava un ruolo assolutamente centrale nei piani dei nazisti: essa, infatti, sarebbe stata lo strumento che avrebbe garantito ai tedeschi la dominazione surrettizia di questa nuova area economica, in quanto il marco, come valuta di riferimento, «avrebbe assunto un ruolo dominante nella politica valutaria europea». I piani nazisti per l’integrazione economica dell’Europa erano tanto politici quanto economici. Come disse Heinrich Hunke, presidente della federazione degli industriali di Berlino, nel 1942: «La necessità di un ordine politico per la cooperazione economica dei popoli è riconosciuta». L’obiettivo, per Hunke e per il regime più in generale, era l’abolizione delle frontiere fra Stati e la creazione di una «unione politica» sotto l’egemonia tedesca.

Questi sono solo alcuni esempi dell’inquietante filo rosso che lega l’europeismo nazifascista degli anni Trenta e Quaranta a quello democratico del dopoguerra. Entrambi hanno un avversario comune, lo Stato nazionale, in cui vedono un regime troppo angusto per la moderna economia globalizzata.
Con ciò, ovviamente, non si vuole sostenere che gli europeisti di oggi siano nazifascisti, né che l’Unione europea possa considerarsi tale. Il punto, piuttosto, è un altro: evidenziare le implicazioni autoritarie e antidemocratiche dell’ideologia antisovranista e mostrare l’infondatezza di una presunta dicotomia tra nazionalismo ed europeismo; spesso e volentieri, infatti, le due cose vanno a braccetto.
Non è un caso che oggi si sia tornati a parlare di “questione tedesca”. In un articolo di qualche anno fa in cui veniva analizzata l’eventuale continuità tra le politiche imperialiste del regime nazista e quelle dell’attuale establishment politico tedesco, persino l’autorevole settimanale tedesco Der Spiegel ha riconosciuto che i sempre più aperti riferimenti al ritorno di un «quarto Reich» non sono del tutto infondati:
«Può suonare assurdo, dato che la Germania di oggi è una democrazia compiuta, senza alcuna traccia di nazionalsocialismo, e dato che nessuno assocerebbe davvero la Merkel al nazismo. Ma una riflessione più attenta sulla parola “Reich”, ovvero impero, potrebbe non essere del tutto fuori luogo. La parola fa riferimento al dominio, con un potere centrale che esercita un controllo su molti popoli diversi. Secondo questa definizione, è proprio sbagliato parlare di un Reich tedesco in campo economico? […] Anche se il dominio di Berlino non è incontrastato, l’eurozona è chiaramente governata dalla Germania. Il paese ha una forte voce in capitolo nel determinare il destino di milioni di individui di altri paesi».

Se oggi lo strapotere della Germania sul continente viene data per scontata, è altresì opinione comune, però, che si tratti perlopiù di un risultato “accidentale”: una egemonia, cioè, che non sarebbe il risultato di un “piano generale” ma che sarebbe emerso quasi per caso – addirittura contro la volontà della Germania – in virtù dell’architettura dell’euro.
Ora, sul fatto che l’architettura dell’euro di per sé avvantaggi la Germania non ci sono dubbi. Ma sarebbe molto ingenuo considerare la progressiva egemonizzazione tedesca dell’Europa cui abbiamo assistito negli ultimi vent’anni come il risultato “imprevisto” dell’architettura stessa dell’unione monetaria o, per questo, del “fondamentalismo economico” della Germania (per quanto il ruolo dell’ideologia non vada sottovalutato); piuttosto, essa andrebbe vista come il frutto di una precisa strategia da parte delle élite politiche ed economiche tedesche, in linea con una vocazione imperialista che ha radici molto profonde nel paese e che potremmo definire “strutturalmente congenita” alla nazione tedesca fin dalla sua nascita. In questo senso, possiamo ipotizzare che esista un filo rosso che lega l’attuale fase di egemonizzazione continentale con i precedenti tentativi di egemonizzazione nel corso del XIX e XX secolo.
La questione tedesca sembrava essere stata finalmente risolta in seguito alla Seconda guerra mondiale, con la divisione in due del paese e con l’integrazione della Repubblica Federale nel blocco occidentale: le classi dirigenti e intellettuali tedesche, infatti, sembravano aver definitivamente rinunciato all’idea di “germanizzare l’Europa” a favore dell’“europeizzazione” della Germania.
In verità, dietro le quinte, le idee “geopolitiche” che avevano ispirato le tragiche esperienze della Prima e della Seconda guerra mondiale riemersero quasi subito, seppur in una veste diversa, ossia in una scuola di pensiero – comunemente definita neomercantilista – che sostituiva alla logica (ormai tabù) della concorrenza militare tra nazioni quella della concorrenza economica. Alla base del neomercantilismo vi è l’idea che, poiché gli Stati e le imprese in essi situate sono in perenne concorrenza tra di loro per il controllo di quote di mercato, l’obiettivo primario della politica economica debba consistere nella realizzazione di saldi attivi nella bilancia dei pagamenti (che a loro volta determinano l’accumulo di riserve finanziarie) nei confronti del resto del mondo o di regioni ritenute particolarmente importanti (come l’Europa), da ottenere tramite la massimizzazione delle esportazioni (attraverso la massimizzazione della competitività di prezzo dei beni dello Stato in questione, facendo prevalere nel paese una inflazione minore che altrove) e la minimizzazione delle importazioni (attraverso la compressione della domanda interna).

Che la logica neomercantilista sia in grado di dispiegare al meglio i suoi effetti all’interno di una zona a cambi fissi è fin troppo ovvio. Questo è il motivo per cui la Germania ha sempre insistito affinché l’Europa adottasse dei regimi di cambio fisso: essa, infatti, ha giocato un ruolo cruciale prima nella creazione del “serpente monetario”, poi del Sistema monetario europeo (SME) e infine dell’euro.
Secondo la storiografia ufficiale, l’euro fu, per così dire, il pegno che la Germania accettò di pagare, suo malgrado, per la riunificazione. Ma è veramente così? Se, da un lato, è senz’altro vero che l’ingresso della Germania nell’euro non godeva di un ampio consenso tra la popolazione tedesca, restia ad abbandonare l’amato marco – «Ho agito come un dittatore», avrebbe poi detto Helmut Kohl, cancelliere tedesco dal 1982 al 1998, in merito alla pervicacia con cui perseguì l’obiettivo dell’unione monetaria, in barba all’ostilità dell’opinione pubblica –, è altresì vero che le élite tedesche, a partire dallo stesso Kohl, erano perfettamente consapevoli che l’euro – per come si è andato strutturando fin dai suoi albori, anche per merito delle pressioni tedesche – sarebbe stato totalmente funzionale agli interessi del capitalismo tedesco.

Tanto che già nel 1991 – cioè prima ancora della firma di Maastricht – il ministro delle Finanze tedesco Theo Waigel poté annunciare trionfalmente ai suoi connazionali che il governo stava «portando il marco in Europa». In tal senso, le insistenze dei dirigenti tedeschi affinché l’euro avesse le stesse caratteristiche del marco non possono essere considerate semplici manifestazioni di rigore ideologico – come una lettura semplicistica del ruolo giocato dalla Germania nella costruzione europea potrebbe far desumere –, ma andrebbero viste come il risultato di un disegno preciso, finalizzato a ristrutturare l’Europa secondo il modello, caro agli intellettuali tedeschi, dei cerchi concentrici, caratterizzato dunque da un Kern, un “nocciolo duro” centrale dominato dalla Germania, e una grande periferia, formata dai paesi della Peripherieländer: i paesi dell’est Europa, quelli del Mediterraneo e sempre più anche la stessa Francia.
Da questo punto di vista, era ben chiaro ai politici e soprattutto agli industriali tedeschi dell’epoca – più di quanto non lo fosse ai politici e agli industriali dei paesi “concorrenti”, è lecito ipotizzare – che l’euro avrebbe enormemente beneficiato l’economia tedesca, permettendogli di competere vantaggiosamente con i suoi principali partner europei, soprattutto in virtù del calmieramento artificiale del tasso di cambio tedesco garantito dalla moneta unica. I responsabili della politica economica tedesca sapevano bene che c’era un solo modo per evitare un apprezzamento certo del marco e soddisfare così le esigenze della propria industria dell’export: ingabbiare il resto dell’Europa nella stessa area valutaria. Possiamo dunque affermare che, contrariamente a quanto recita la vulgata, «la spinta verso il cambio fisso è stata fortissimamente voluta dalla Germania», in linea con la filosofia neomercantilista delle sue élite.
A dispetto della retorica ufficiale di Kohl e degli altri dirigenti tedeschi dell’epoca, possiamo dunque concludere che per le élitetedesche l’ingresso nell’Unione europea e nell’euro non avesse lo scopo di “europeizzare la Germania” quanto quello, già tentato altre volte nella storia, di «germanizzare l’Europa», come notava già nel 1995 la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Ha ben riassunto la questione lo storico tedesco Hans Kundnani: «Per la Germania “più Europa” ha sempre significato “più Germania”». Da questo si evince quanto sia ingannevole la dicotomia spesso sollevata nel dibattito pubblico tra “nazionalismo” ed “europeismo”. Le due cose, spesso e volentieri, vanno a braccetto. E la Germania è lì a dimostrarlo