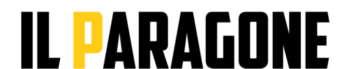di Luca Pinasco.
Con i “paletti” fissati dalla Commissione europea nella comunicazione del 17 settembre, alla già appurata inconsistenza quantitativa del Recovery Fund (al netto poco più di 20 miliardi in 6 anni) e intempestività (i primi fondi saranno erogati alla fine del primo semestre 2021) si aggiunge la inadeguatezza dei settori d’intervento prescelti.
Come spiega nel comunicato Ursula von der Leyen: «Gli Stati membri necessitano di orientamenti chiari per garantire che i 672,5 miliardi di euro siano investiti sia per l’immediata ripresa economica dell’Europa, ma anche per una crescita sostenibile e inclusiva a lungo termine».

Dunque i piani di spesa nazionali, i quali saranno sottoposti passo dopo passo ad una negoziazione con un comitato ad hoc, per essere approvati dovranno riguardare sette specifici settori: promuovere l’energia pulita; migliorare l’efficienza energetica degli edifici pubblici e privati; sviluppare nuove tecnologie nei trasporti; rafforzare la rete di banda larga, in particolare 5G; digitalizzare la pubblica amministrazione, il settore giudiziario e sanitario; cavalcare l’economia dei dati; e adattare il sistema educativo alle nuove necessità. Con il vincolo di dedicare il 37 per cento dei fondi alla transizione climatica e il 20 per cento alla transizione digitale.
Questi obiettivi, già di per sé poco inclini rispetto ai problemi reali delle economie europee, si concretizzano in Italia in un Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) costruito sulla base del Piano Colao, continuamente modificato per rispondere meglio alle linee guida europee, cosa che lo rende sempre più confuso e meno utile ad affrontare la drammaticità della crisi attuale. Le tre macro-aree individuate dal governo nelle linee guida presentate al Parlamento sono: digitalizzazione, green economy e parità di genere. Ora, prima di entrare nel merito di tali nobili indirizzi, bisogna avere chiari i termini in cui si pone tale questione: ci andremo a fare carico di un grosso debito per finanziare una politica industriale, il che sarebbe cosa buona e giusta se non fosse che la Commissione ci obbliga a spendere i soldi presi in prestito su investimenti che poco hanno a che fare con le caratteristiche strutturali dell’economia italiana. Con l’aggravante di dover in un passaggio successivo tagliare la spesa pubblica per cose invece necessarie, in modo da poter ripianare il debito creato.
Adesso, entrando nel merito, appare subito evidente che di merito c’è poco e nulla. Una politica di spesa finanziata con debito è un ottima soluzione per uscire dalla recessione quando ha effetti moltiplicativi sulla domanda aggregata. Cosa molto distante rispetto agli interventi proposti. Promuovere l’energia pulita vuol dire nell’ottica europea defiscalizzare ipotetici consumi che comunque non vengono fatti a causa del basso reddito. Defiscalizzare consumi/investimenti ipotetici ha un effetto moltiplicativo irrisorio rispetto a quello che avrebbe una spesa pubblica finalizzata all’acquisto degli stessi beni (teorema di Haavelmo).

Come evidenzia Stirati, investimenti sul settore energetico andrebbero fatti costruendo enti pubblici capaci di svolgere autonomamente ricerca, occupando e dando reddito a personale altamente qualificato, e producendo in tal modo beni e metodi capaci di rendere più “green” il consumo energetico pubblico e privato. Una “IRI dell’innovazione”, per dirla con Aresu. Perché, sia chiaro, di investimenti pubblici “una tantum” la nostra economia allo stato attuale non se ne fa nulla.
Per risolvere i problemi della scuola non serve modificare i piani di studio, come proposto, quanto invece assumere nuovi docenti a tempo indeterminato e mettere in sicurezza le strutture esistenti se non costruirne nuove dando impulso al settore delle produzioni edilizie. Far funzionare la sanità non vuol dire trasformare gli ospedali in “aziende ospedaliere” e chiudere quelli in deficit, ma vuol dire aprire nuovi ospedali e assumere nuovo personale medico. Sviluppare nuove tecnologie dei trasporti non vuol dire nulla se nel sud Italia non ci sono strade piane, le ferrovie hanno un binario e i treni si muovono a velocità ottocentesche.
Solo un massiccio investimento pubblico può risolvere tali problematiche. E saranno i redditi di ricercatori, insegnanti, muratori, medici, che faranno ripartire l’economia. E allora la spesa pubblica diventa consumi, i consumi spingono gli investimenti, la domanda aggregata resuscita e l’economia riparte. Alla fine questo debito fa crescere il prodotto nazionale, crea lavoro e lascia ospedali, strade e scuole alle future generazioni. Soltanto così il debito del Recovery Fund potrebbe avere un senso. Ma questo è quanto di più distante ci sia dal debito del Recovery Fund, un debito fatto per spese correnti, un deficit temporaneo da indirizzare su beni perlopiù di importazione, incapace di produrre lavoro e da ripianare al più presto con tagli alla spesa.
Ci chiediamo dunque, perché dobbiamo indebitarci per “cavalcare l’economia dei dati”, “i big data”, “la green economy”, “il microcredito alle start-up aperte da donne” (tutto ricompreso nel PNRR) ed essere per di più giudicati su tutta questa roba che con la nostra struttura economica ha poco a che fare, quando invece potevamo indebitarci di tasca nostra e investire su ciò che siamo e sulle nostre esigenze, come l’aerospaziale, l’edilizia, il farmaceutico, la cantieristica, la componentistica elettronica, gli ospedali e le scuole? La risposta è semplice: perché ce lo vieta l’Europa.