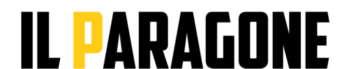“Penso al recupero dei criminali, delle puttane e dei transessuali. Penso allo stress degli alluvionati, al tempo libero dei carcerati. Penso alle nuove povertà che danno molta visibilità. Penso che è bello sentirsi buoni usando i soldi degli italiani. È il poter dei più buoni, il potere dei più buoni…”. Ci voleva coraggio a essere Giorgio Gaber.
In questi giorni di riposo ho ripreso i miei vecchi cd e fuori dall’internet delle cose non ho avuto bisogno né di streaming né di chiedere ad Alexa che musica mi consigliasse. Ho ascoltato Gaber e ripreso alcuni vecchi libri, come se tutto mi stesse chiamando captando l’eco delle polemiche dei panettoni, degli influencer, della solidarietà.
Nell’album “Un’idiozia conquistata a fatica”, Gaber infilzava il buonismo dopo averlo definito a suo modo. Ne denunciava la redditività. La manipolazione. Il “Potere dei più buoni”, appunto, brano anticipato – come accadeva nel suo teatro canzone – da un monologo: l’azalea. Ne trascrivo un pezzo: “Un’azalea per questo, per quest’altro, per quest’altro ancora; dato che non funziona niente si risolve tutto con le azalee. E mi bussano alla porta, mi fermano per la strada, mi corrono dietro, col motorino, con la bicicletta e io stremato, che faccio? Compro un’azalea, per salvare bambini, animali, piante, ricerche varie, bacini idrici, le suore del Nicaragua, le foreste dell’Amazzonia. Devo fare tutto io!”.

Straordinario. Potente, tanto potente da connettersi per magia con tre libri che mi puntavano dalla libreria: “L’industria della solidarietà” di Linda Polman; “La carità che uccide” scritta dall’economista africana e di colore Dambisa Moyo; e il più recente “L’industria della carità” di Valentina Furlanetto che Chiarelettere ha rimesso in libreria con una premessa alla nuova edizione: “La prima edizione del libro è del 2013”, scrive l’autrice. “In dieci anni è cambiato poco nei fatti e molto nella sensibilità. Allora criticare le ong era un tabù. Svelare le opacità di certi bilanci, denunciare lo strapotere di talune organizzazioni, gli sprechi, le contraddizioni fra intenzioni e prassi di altre era considerato inappropriato”. Effetto di “una benevolenza totalmente acritica”.
In effetti è così: criticare i buoni ti fa diventare… cattivo; è questa la manipolazione del potere. E in queste settimane del caso Ferragni, ecco che il bubbone scoppia in ogni suo aspetto. Perché un ospedale pubblico o un’associazione che si prende cura dei più deboli (ma potremmo citare un sacco di situazioni nel campo del terzo settore) deve agganciarsi direttamente o indirettamente con influencer, calciatori, attrici, cantanti, insomma coi vip? E com’è possibile che solo dopo tanto tempo si viene a sapere quanto finisce per lo scopo nobile e quanto nelle spese che appaiono accessorie (comunicazione e marketing)? Pretendere trasparenza significa mettere il donatore protagonista del progetto, renderlo attore attivo e non passivo. Ma poi c’è altro: i controlli nel terzo settore sono puntuali? Perché si ha paura di parlare delle opacità delle ong? E infine la guerra tra i… buoni. Lo spiega bene nel suo libro Valentina Furlanetto, quanto si deve spendere in campagne acchiappafondi: la gente che chiede i soldi ai banchetti è parte di una macchina costosa. “L’industria della carità” fa nomi e cognomi, cita tutti da Medici senza Frontiere ad ActionAid passando per l’Airc, dal Wwf a Greenpeace. “Ho ricevuto molte critiche, aggressioni verbali e velate minacce. Nessuna querela, prova del fatto che i numeri erano quelli”.

Attaccare la Ferragni ora è facile, prima avevano paura della sua macchina social. Lo stesso valeva per Soumahoro, il sindacalista dei braccianti, degli ultimi. L’uomo buono come da copertina del cattocomunista Marco Damilano quando dirigeva l’Espresso. Vedremo come andrà a finire ma una cosa è certa: perché nessuno ha mai voluto accertare prima? Eppure le segnalazioni c’erano. Forse perché Soumahoro come Fedez servivano nel presepe dei Buoni contro i Cattivi.
La disperazione, la malattia, l’emarginazione, l’immigrazione, la povertà sono prodotti da vendere come altri prodotti promuovendo costose analisi di mercato, organizzando campagne stampa. Magari con le foto dei bambini africani in bella mostra. Dambisa Moyo nel suo racconto di come “gli aiuti dell’Occidente stanno devastando il Terzo mondo” racconta che “negli ultimi trent’anni i Paesi maggiormente dipendenti dagli aiuti hanno mostrato un tasso medio di crescita annuale del meno 0,2 per cento; tra il 1970 e il 1998, quando si registravano i più alti aiuti all’Africa, il tasso di povertà nel continente salì dall’11 per cento a un spaventoso 66%”, questo perché – secondo l’economista africana – i prestiti e le sovvenzioni sortiscono lo stesso effetto del possesso di una preziosa risorsa naturale.
Anche “L’industria della solidarietà” di Linda Polman racconta di “Quarantamila organizzazioni internazionali, oltre sei miliardi di dollari stanziati ogni anno: intorno agli aiuti umanitari si è sviluppata una vera e propria industria (la quinta nel mondo). Animate – oggi come alla loro origine – da scopi nobilissimi, ma anche obbedienti alle leggi di mercato, le ONG entrano in concorrenza fra loro per ottenere spazi di intervento e lottano per guadagnare visibilità mediatica”.
Oltre le raccolte fondi c’è un mondo fatto di soldi buttati, di manager con stipendi d’oro (“per 4 euro che arrivano alla gente, se non spendono milioni per tutt’altro”), di lavoratori sfruttati e persino di scarsa democrazia interna. Ma assolutamente redditizio: “Se fosse quotata a Wall Street, l’economia del bene peserebbe quanto Apple prima dell’IPhone 5”. Aveva ragione Gaber.